
Donato
Faruolo è nato a Potenza nel 1985.
Studente di Ingegneria Edile e Architettura, si interessa in modo libero ed indipendente di arti visive. Ha scritto articoli sull’arte e l’architettura contemporanea per il sito di Amnesiac Arts. Ha partecipato con opere fotografiche a diversi concorsi, esposizioni, pubblicazioni: “Frattura Scomposta” (rivista d’arte on line), “Under Urban Mask” (finalista per l’edizione 2006 del concorso indetto dall’associazione State of Art), “L’arte tra il visibile e l’invisibile” (collettiva presso il Museo Provinciale di Potenza), “Sardegna Arte Fiera 2006” (“Fight-Contrasti” per Amnesiac Arts” curata da Barbara Improta e Massimo Lovisco).
Studente di Ingegneria Edile e Architettura, si interessa in modo libero ed indipendente di arti visive. Ha scritto articoli sull’arte e l’architettura contemporanea per il sito di Amnesiac Arts. Ha partecipato con opere fotografiche a diversi concorsi, esposizioni, pubblicazioni: “Frattura Scomposta” (rivista d’arte on line), “Under Urban Mask” (finalista per l’edizione 2006 del concorso indetto dall’associazione State of Art), “L’arte tra il visibile e l’invisibile” (collettiva presso il Museo Provinciale di Potenza), “Sardegna Arte Fiera 2006” (“Fight-Contrasti” per Amnesiac Arts” curata da Barbara Improta e Massimo Lovisco).
"Ours
is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm
has happened, we are among the ruins, we start to build up new little
habitats, to have new little hopes. It is rather hard work: there is now
no smooth road into the future: but we go round, or cramble over the obstacles.
We've got to live, no matter how many skies have fallen."
(D. H. Lawrence)
L’ASTIGMATISMO ESISTENZIALE
Riflettere sulle cose o riflettersi sulle cose. Una paradossale intervista
a Donato Faruolo.
di B.W.
D.F. Ormai ho rinunciato a voler vedere le cose. Non
serve più a niente.
B.W. Perché giungere a decretare inutile un rapporto sensoriale
diretto con le cose?
D.F. Perché nei nostri tempi bulimici, sazi fino alla nausea di
sollecitazioni sensoriali, informazioni e conoscenze, nulla ha più
senso: non sappiamo di sapere e non siamo in grado di usare ciò
che sappiamo, studiamo integrali e tavola periodica a liceo ma non ne
comprendiamo il senso profondo, sappiamo a cosa ci porteranno i nostri
stili di vita e regimi politici, ma non muoviamo un solo passo in maniera
risolutiva, programmatica, decisiva, per tentare di evitare la catastrofe.
La convinzione di essere in grado di trovare un senso a tutto ciò
che vediamo è diventata pian piano latente abbandono alla speranza
che le cose che vediamo siano in grado già da sole di risolversi
nei nostri pensieri. Vedere e basta: un gesto estetico privo di estetica.
B.W. In che modo privarsi della percezione sensoriale si configura come
reazione legittima all’interno di questo scenario?
D.F. Probabilmente non è una reazione legittima. E’ solo
una reazione umana, tutto qua. Anni fa ho cominciato a credere che l’unico
modo per crescere davvero fosse giungere con l’intelletto alla realtà
dell’esistenza, e non alla sua opinabilità, decenza, convenienza,
correttezza, e che per fare ciò fosse necessario demolire ogni
convinzione frutto di pigra accondiscendenza verso se stessi e verso la
presunta innocenza di chi o cosa ci fornisse nozioni.
In questo modo alla realtà non sono mai arrivato, ma se non altro
conosco un po’ più da vicino la menzogna.
B.W. Come hai deciso che “vedere le cose” non valesse più
la pena?
D.F. Non si è trattato di un lucido proposito, né dell’applicazione
rigorosa di un imperativo ideologico che portasse alla costruzione di
un’alternativa praticabile: un giorno ho smesso semplicemente di
preoccuparmi delle prassi di ordinaria manutenzione della vita, relegandole
in una parte stagna della mia memoria cellulare, per lasciare tutto il
resto dell’attenzione a strani, contorti, ambigui processi di rielaborazione
delle percezioni.
Alle volte capita, per esempio, che prenda una porta in faccia per aver
stimato superfluo vederla e futile il pensiero dell’aprirla o che
abbia lasciato che le mie cornee si corrugassero per distorcere le immagini,
così da convincermi in modo suicida e brutalmente carnale della
profonda problematicità dei rapporti tra l’intelletto e le
cose, fino ad arrivare all’opacizzazione, all’espulsione,
al rigetto, con l’atteggiamento di chi sbriga una noiosa pratica
burocratica. Ora che non posso più permettermelo, invece, infilo
gli occhi nei bicchieri per guardare le cose attraverso il loro fondo,
prendo il binocolo per scrutare le valli incise sul palmo della mia mano,
guardo il cielo puntando lo sguardo in basso in direzione del suo riflesso
sul parabrezza di un’auto, focalizzo le righe di un libro con un
occhio o con l’altro e mescolo le due visioni separate, guido in
autostrada senza azionare i tergicristalli quando piove…
B.W. Era inevitabile che il tuo occhio finisse anche nel mirino di una
macchina fotografica…
D.F. La mia macchina fotografica è un meraviglioso strumento terapeutico,
più che artistico, perché probabilmente ha il mio stesso
modo di cogliere ciò che è percepibile con gli occhi: è
un oggetto idiota che di ciò che vede non sa che farsene, un adorabile
sguardo ebete sulle cose ebeti, un sensore incapace di provare ribrezzo
né piacere, di avere pregiudizio né giudizio. Allo stesso
modo la Fotografia, coscienza alienata dell’idiota strumento, va
amorevolmente alla ricerca di una salvezza qualsiasi per ciò che
vede: inventa l’artificio della superficie, il gioco al frainteso
dell’inquadratura, il retropensiero del finzionario.
B.W. Quali sono i vantaggi del salto nella dimensione “finzionaria”
della fotografia?
D.F. Nello spazio riparato dell’inquadratura, la visione si tramuta
nel soggetto di una rappresentazione scenica che con il reale non vuole
avere nessun rapporto mimetico, ma che proprio per il fatto di non essere
invischiata nelle sporche faccende di una pseudo-realtà, può
rivelare verità pesanti come macigni con l’animo leggero
dell’unico testimone oculare che sa e riferisce, ma che non ha compiuto
il delitto.
B.W. E allora, tutta questa realtà che resta sullo sfondo, che
pare essere indispensabile e trascurabile al tempo stesso, sembra quasi
non avere più ragione di esistere. Perché non dissociarsi
e basta? Perché fotografare invece di chiudere semplicemente gli
occhi? Qual è il senso della rappresentazione della crisi?
D.F. Tutto sommato, il mondo potrebbe anche non esistere. Ma “non
vedere” è il tentativo un po’ disperato di trovare
la realtà nel fondo del sentire umano, dove ristagna il senso dolente
di questo rapporto spezzato tra creatura e creatore, per riportare a galla
tutto il male che l’uomo vuole a se stesso nel tentare di farsi
degli sconti sul prezzo della vita: non c’è vera esistenza
senza l’instabilità di dubbio, non c’è futuro
nella falsità di un appagamento formale. La realtà è
ormai un fantasma che aleggia al di là delle cose. La consistenza
degli oggetti non ha valore se, presi dalla smania del vivisezionatore
analitico, non prendiamo in considerazione il senso che il percettibile
acquista nel suo adagiarsi sulle coscienze umane, collettive ed individuali.
Delineare una realtà che esiste di per sé è un gioco
stanco per teocratici e demagoghi.
E’ nell’assenza stessa dei contorni che si annida la definizione
delle cose.
GUARDANO.jpg)
Le cose non mi (ri)guardano

Il latente fascino del fastidio

Quindi non

Quando piove
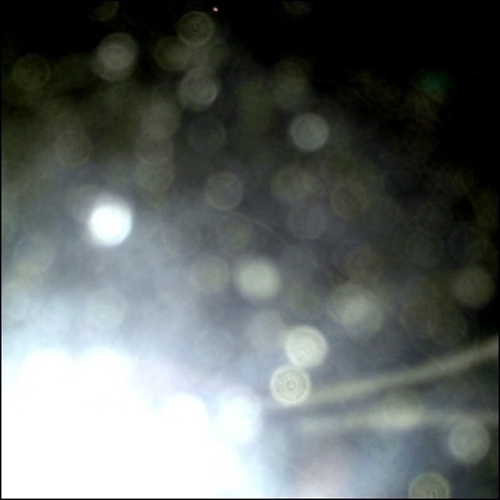
Dimmi che non è vero

Terra d'asilo per sguardi caduti