

Sedia 'Nandor' di Ikea
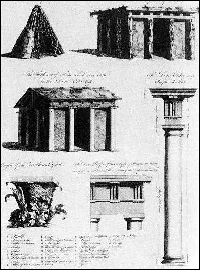
Un'illustrazione da 'Essai sur
l'Architecture' di Laugier

La Nationalgalerie di Berlino
di Mies Van Der Rohe
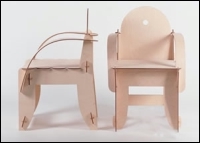
Un esempio di design secondo
Paolo Cogliati,la sedia'Ciclope'
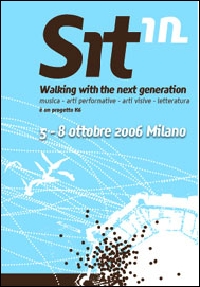
Banner per Sit in Milano 2006

Esterno del Padiglione Francese
alla 10a Mostra Internazionale
d'Architettura di Venezia

Interno del Padiglione Francese

Assonometria per l'allestimento
del Padiglione Francese
24 maggio 2007
DAVIDE VS GOLIA.
La Capanna di Laugier. Ovvero, restringere il campo d’applicazione
della legge umana per salvarne la validità.
di Donato Faruolo
Dall’uomo al mondo, dal
mondo all’uomo attraverso il progetto.
Come si tenta di sopravvivere alla constatazione di vivere dentro qualcosa
che non è se stessi: Modus e Modum, reazione e azione, immanenze
e trascendenze, orizzonti, vincoli e deliri vari di onnipotenza.
Il primo di due articoli speculari su Design e Architettura.
Nandor di Mikael Warnhammar è l’equivalente
in forma di sedia della capanna primitiva di Laugier: per entrambe, individuati
gli obiettivi-problema, l’oggetto-soluzione è sintetizzato
in base a semplici combinazioni di ciò che è offerto dall’ambiente
di origine, distinguendo ogni parte in base agli specifici rapporti che
sussistono tra forma e funzione del componente e caratteristiche dei materiali
impiegati. Quella che per Laugier doveva essere “la natura”,
per Ikea è l’industria. E se l’industria produce rattan
e sbarre di acciaio, basterà lasciare che le sbarre di acciaio
semplicemente sagomate assolvano la funzione di sostenere il peso e mantenere
la foggia, e che il rattan formi la tessitura delle superfici sulle quali
si distribuirà il peso del corpo. Nella capanna di Laugier, allo
stesso modo, i semplici tronchi di legno sostenevano il peso del tetto
mentre le arti della tessitura fornivano l’edificio di superfici
che fungessero da delimitazione tra il qui e l’altrove.
La forma dell’oggetto è la rappresentazione chiara del processo
mentale di comprensione smaliziata e di sfruttamento consapevole dell’ambiente
e si configura come il manifesto di uno spazio circoscritto dell’onnipotenza
umana.
E’ questo l’atteggiamento di Davide con Golia.
Il mondo è un sistema organizzato ed ordinato all’interno
del quale è possibile agire solo fruttando la conoscenza che si
ha del sistema stesso. Non c’è misticismo o mistificazione
che tenga: se l’iniziativa umana sorge dalla necessità di
soddisfare un’esigenza ineluttabile, non c’è ragione
per cui si debba pensare che l’ingegno umano si possa legittimamente
disperdere nel tentativo di soddisfare false istanze che non potranno
avere che false risposte. Ciò che non giustifica di per se stesso
la propria esistenza, rendendo evidente nello stesso atto del manifestarsi
la propria causalità, appena immesso nel sistema-mondo sarà
corroso irrimediabilmente dalla vanità dei propri presupposti e
sarà espulso dal sistema perché riconosciuto come elemento
estraneo.
Se Davide vuole uscirne vivo -e non semplicemente vincitore- farà
bene a non prendere in giro se stesso, perché potrebbe non avere
l’opportunità di imparare da un suo eventuale errore.
Come in natura non esiste nulla che non sia stato passato sotto la revisione
e la verifica della selezione naturale, così il gesto umano non
può resistere e non ha ragione di sussistenza senza essere manifestazione
ineluttabile ed auto-rappresentativa di causalità.
Davide vince su Golia grazie alla propria capacità di interpretare
l’ambiente e farne strumento del proprio intelletto. La sua vittoria
celebra se stessa perché è il tipico caso di storia scritta
dal vincitore: è un mito umano tramandato con i mezzi della comunicazione
umana, una questione di intelletto che rappresenta catarticamente la possibilità
dell’intelletto stesso di avere la meglio sulla brutalità
della forza.
Non è un caso che “i classicismi” architettonici si siano manifestati con maggior compiutezza in periodi di particolare fiducia nella capacità di fare dell’intelletto umano. Ma se tutti i classicismi preindustriali, quelli sintetizzati da Laugier, erano fondati sull’armonia e coerenza di utilizzazione di un modulo-misura come indizio naturale di un ordine superiore, il senso del classicismo industriale si esprime il più delle volte nel tentativo di armonizzare il processo costruttivo dell’architettura con il processo produttivo dell’industria nell’applicazione coerente di un modulo-oggetto (semilavorati industriali, impianti per la produzione di elementi prefabbricati e componenti standardizzati) che porti alla definizione, ancora una volta, di un canone che è esterno all’architettura stessa. L’architettura, in sostanza, quale prima delle arti pratiche, si realizza nel non sovrapporsi all’ambiente che la genera ma nel configurarsi come parte circoscritta del tutto, ingranaggio della macchina del creato, dell’industria o della società in divenire.
Padre e massimo esponente del “classicismo industriale”
dell’architettura è Ludwig Mies Van Der Rohe, che, combinando
profilati standard di produzione industriale, reinventa la colonna classica
con il suo pilastro a croce e, lasciando in evidenza la testa della trave
che si innesta perpendicolarmente sull’architrave, rigenera ex-novo
la funzione di un elemento come il triglifo. Null’altro che chiarezza
del processo di costruzione e adempimento della funzione: l’architettura
ritorna classica, seppur per vie traverse ed in modo quasi inaspettato.
Per resistere alle turbolenze dell’avvicendarsi delle stagioni,
l’uomo sceglie lo spazio riparato della razionalità, dove
non ci sia più nulla da imputare all’uomo-architetto, battezzato
dal peccato originale dell’arbitrarietà del suo agire e consacrato
al pragmatismo della reazione vincolata.
Figli, forse illegittimi e sicuramente inaspettati, di queste istanze
di moralizzazione dell’architettura, sono le moderne teorie e pratiche
di architettura e design bioecologico e le varie esperienze di democratizzazione
dell’abitare, tutte pratiche del pensiero architettonico sempre
più lontane dalla figura dell’architetto-scultore (realizzatore
di opere) e sempre più vicine all’idea dell’architetto-tecnologo
(ideatore di soluzioni) di cui Renzo Piano è il massimo esempio.
Queste sono alcune tra le manifestazioni più eclatanti e significative
degli ultimi anni.
Paolo Cogliati supera l’idea di un’architettura alla ricerca
della sintonia con un’industria fatta di standardizzazione per pezzi
che fungano da modulo-oggetto e arriva a disegnare una casa di pannelli
lignei progettati al computer e tagliati al laser che per essere montati
non necessitino di viti o colle e che, con una serie di pezzi combinati
ad incastro in diverse configurazioni, generino ambienti autonomi con
arredamenti integrati. Il design, in questo caso, è puro manifesto
di architettura “digitale” e responsabile, dove l’incastro
(anche vistoso) tra due pezzi diversi ha dignità di permanenza
per il fatto di essere irrimediabilmente connesso alla scelta ideologica
di versatilità ed ecologia tesa ad evitare prodotti chimici, sprechi
o impiego di parti metalliche.
Adriana Labella, a partire da un’unica lastra di legno di dimensioni
standard, traccia mediante il disegno digitale le parti di un oggetto
tridimensionale da arredamento che possa essere facilmente assemblato
e che non generi prodotti di scarto. Se il design tradizionalmente inteso
è scelta arbitraria tra una delle infinite possibilità disponibili
di risolvere il problema, usare come discrimine il criterio dell’economia
e dell’ecologia rende “etico” il prodotto che ha così
maggiori possibilità di resistere con forze proprie nel sistema-mondo.
Le performance di design alternativo al SITinMilano del 2006, con la realizzazione
delle Cadegre, opere di eco-design ottenute dall’assemblaggio di
bancali di risulta, dimostrano come si possa superare addirittura l’idea
che il design debba avvalersi e allearsi preventivamente con l’industria,
disconoscendone il ruolo “ordinatore” e puntando il dito sui
fallimenti di una concezione antiquata del rapporto tra uomo e ambiente,
in una specie di regime d’emergenza in cui la questione formale
reale non può che essere solo una lettura a posteriori della stessa
questione morale di riduzione dell’impatto.
Il padiglione francese per la 10. Mostra Internazionale di Architettura
alla Biennale di Venezia è invaso da un’architettura iper-democratica
in metastasi costituita di pezzi tubolari d’acciaio, giunti fissi
e piattaforme da impalcatura. La compostezza classica dell’edificio
è attaccata da ponteggi che generano qua e là, nella tridimensionalità
dello stanzone, cellule abitabili che penetrano e reinterpretano con la
cinica, dirompente ironia della vita ogni spazio esistente e ne creano
di nuovi, con cuccette, scale, salotti, cucine, ponti sospesi e torri
svettanti sulla laguna fornite di amaca sulla cima. L’estetica dell’architettura
coincide con la ragione pratica del proprio esserci. Il progetto si vaporizza
nei mille rivoli del divenire: ognuno può agire sul manufatto architettonico
perché esso non ha una dignità che sussista al di sopra
delle cose e la figura dell’architetto-santone muore annegata nella
ficcante accusa di narcisismo onanista mossagli contro dall’irriverenza
del vivere reale.
Se non bastasse tutto ciò a configurare l’esperienza giocosa
del padiglione francese come la più assurdamente ragionevole tra
le proposte in biennale, basterà leggere il titolo dato a questa
improbabile macchina da vita e da vivere per comprendere quanto “corrosivo”
possa rivelarsi un esperimento simile per la sacralità di molte
archistar del momento: “Le pur plaisir d’exister”. Vale
a dire, il fatto che l’architetto viva di architettura non è
sufficiente a spiegare perché spesso ci si dimentichi che, da parte
sua, l’architettura non viva per altro che per essere vissuta.